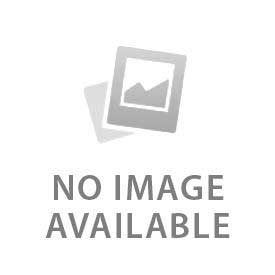La profondità è un motivo ricorrente nell’immaginario contemporaneo; la rappresentazione degli spazi sotterranei e sottomarini è diventata sempre più frequente nella letteratura, nel cinema, nelle arti figurative. In particolare, risaltano sempre più spesso elementi e oggetti materiali che emergono dalla profondità: rocce, fossili, ossa, scorie, petrolio. L’attrazione esercitata dal mondo sotterrano è sempre stata forte: la scoperta di tesori sepolti o sommersi, i viaggi al centro della Terra e le discese negli inferi sono archetipi che hanno sempre avuto grandissima fortuna nel mito e nella religione, nella letteratura e perfino nella scienza. Ma la profondità nella cultura contemporanea ha un carattere specifico, che consiste nel legame con l’Antropocene, l’epoca cioè in cui l’attività umana è diventata così intensa da incidere sui processi geologici, alterando clima e struttura del pianeta.
Nell’immaginario classico e moderno, lo spazio profondo era un territorio di scoperta o di conquista, in senso materiale o morale: dalla catabasi l’eroe torna dopo aver raggiunto uno status diverso e migliore, come in un rito iniziatico. La profondità era un luogo d’eccezione, obiettivo di un passaggio temporaneo, funzionale al tempo dell’avventura e del rito. È lo spazio “notturno”, concepito come immagine contraria di quello “diurno” della superficie in cui si riflette e da cui si dipende, che garantisce al protagonista un più saldo possesso di entrambi i regni, quello sotterraneo e quello di superficie. In questo senso, l’immagine che restituisce è quella dell’uomo che ha superato pericoli e ostacoli: il trionfo dell’antropocentrismo, insomma. Il paradigma che si instaura, invece, nell’immaginario contemporaneo ha caratteristiche diverse se non opposte. Lo spazio non viene conquistato ma piuttosto rivelato; la sua manifestazione non è temporanea ma permanente, preesiste all’umano e perdura oltre di lui, nel tempo profondo. La sua funzione non è quindi quella di esaltare la virtù dell’eletto, ma di relativizzarne la sua condizione in rapporto alle altre specie e alla materia stessa. “Profondità” diventa così una parola chiave dell’Antropocene e del pensiero ecocritico.
In questo libro sorprendente e ricchissimo, con esempi tratti dalla letteratura, dalla scrittura scientifica, dal cinema, dalle arti figurative, Niccolò Scaffai definisce il “paradigma della profondità” illuminando tutta la cultura contemporanea, analizzandola attraverso i cardini del testo e delle sue strutture, cioè il tempo e lo spazio, e spiegandoci come la letteratura e le altre forme dell’immaginario riescono a collegare gli spazi profondi con gli ambienti di superficie in cui si svolge la nostra esistenza. Perché conoscere, cioè accedere alla profondità, è la condizione per portare alla luce e indicare l’esempio virtuoso di una forma di vita non antropocentrica.
Niccolò Scaffai è docente di Critica letteraria e letterature comparate all’Università degli Studi di Siena, dove dirige il Centro di ricerca «Franco Fortini». Dal 2010 al 2019 ha insegnato Letteratura contemporanea all’Università di Losanna, ed è membro del direttivo di Compalit - Associazione di Teoria e Storia Comparata della Letteratura. Tra i suoi libri recenti, ricordiamo per Carocci Il lavoro del poeta (2015) e Letteratura e ecologia (2017); per Mondadori i commenti alle opere di Montale La bufera e altro (2019) e Farfalla di Dinard (2021). Per Einaudi ha curato l’antologia Racconti del pianeta Terra (2022). Fa parte dei comitati direttivi e scientifici di varie riviste di studi letterari. Collabora con “Alias Domenica”, “Domenica del Sole 24 ore”, “Le parole e le cose”, “Doppiozero”.
Scopri di più su Aboca Edizioni
La profondità è un motivo ricorrente nell’immaginario contemporaneo; la rappresentazione degli spazi sotterranei e sottomarini è diventata sempre più frequente nella letteratura, nel cinema, nelle arti figurative. In particolare, risaltano sempre più spesso elementi e oggetti materiali che emergono dalla profondità: rocce, fossili, ossa, scorie, petrolio. L’attrazione esercitata dal mondo sotterrano è sempre stata forte: la scoperta di tesori sepolti o sommersi, i viaggi al centro della Terra e le discese negli inferi sono archetipi che hanno sempre avuto grandissima fortuna nel mito e nella religione, nella letteratura e perfino nella scienza. Ma la profondità nella cultura contemporanea ha un carattere specifico, che consiste nel legame con l’Antropocene, l’epoca cioè in cui l’attività umana è diventata così intensa da incidere sui processi geologici, alterando clima e struttura del pianeta.
Nell’immaginario classico e moderno, lo spazio profondo era un territorio di scoperta o di conquista, in senso materiale o morale: dalla catabasi l’eroe torna dopo aver raggiunto uno status diverso e migliore, come in un rito iniziatico. La profondità era un luogo d’eccezione, obiettivo di un passaggio temporaneo, funzionale al tempo dell’avventura e del rito. È lo spazio “notturno”, concepito come immagine contraria di quello “diurno” della superficie in cui si riflette e da cui si dipende, che garantisce al protagonista un più saldo possesso di entrambi i regni, quello sotterraneo e quello di superficie. In questo senso, l’immagine che restituisce è quella dell’uomo che ha superato pericoli e ostacoli: il trionfo dell’antropocentrismo, insomma. Il paradigma che si instaura, invece, nell’immaginario contemporaneo ha caratteristiche diverse se non opposte. Lo spazio non viene conquistato ma piuttosto rivelato; la sua manifestazione non è temporanea ma permanente, preesiste all’umano e perdura oltre di lui, nel tempo profondo. La sua funzione non è quindi quella di esaltare la virtù dell’eletto, ma di relativizzarne la sua condizione in rapporto alle altre specie e alla materia stessa. “Profondità” diventa così una parola chiave dell’Antropocene e del pensiero ecocritico.
In questo libro sorprendente e ricchissimo, con esempi tratti dalla letteratura, dalla scrittura scientifica, dal cinema, dalle arti figurative, Niccolò Scaffai definisce il “paradigma della profondità” illuminando tutta la cultura contemporanea, analizzandola attraverso i cardini del testo e delle sue strutture, cioè il tempo e lo spazio, e spiegandoci come la letteratura e le altre forme dell’immaginario riescono a collegare gli spazi profondi con gli ambienti di superficie in cui si svolge la nostra esistenza. Perché conoscere, cioè accedere alla profondità, è la condizione per portare alla luce e indicare l’esempio virtuoso di una forma di vita non antropocentrica.
Niccolò Scaffai è docente di Critica letteraria e letterature comparate all’Università degli Studi di Siena, dove dirige il Centro di ricerca «Franco Fortini». Dal 2010 al 2019 ha insegnato Letteratura contemporanea all’Università di Losanna, ed è membro del direttivo di Compalit - Associazione di Teoria e Storia Comparata della Letteratura. Tra i suoi libri recenti, ricordiamo per Carocci Il lavoro del poeta (2015) e Letteratura e ecologia (2017); per Mondadori i commenti alle opere di Montale La bufera e altro (2019) e Farfalla di Dinard (2021). Per Einaudi ha curato l’antologia Racconti del pianeta Terra (2022). Fa parte dei comitati direttivi e scientifici di varie riviste di studi letterari. Collabora con “Alias Domenica”, “Domenica del Sole 24 ore”, “Le parole e le cose”, “Doppiozero”.
Scopri di più su Aboca Edizioni